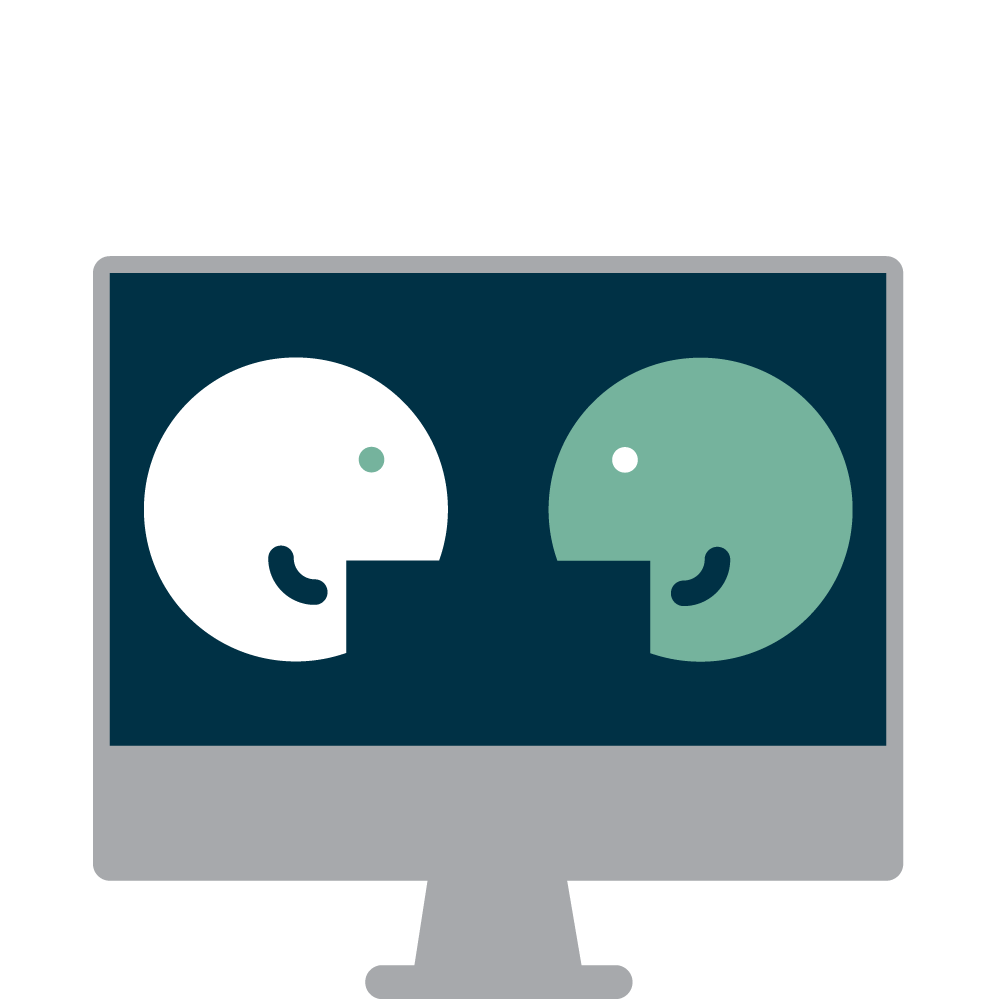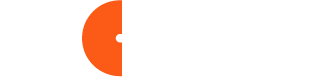Greenwashing: le recenti decisioni dell'Agcm
Published on 13th March 2025
Le azioni giudiziali e le iniziative legislative confermano l'elevata attenzione sul tema della sostenibilità, imponendo alle imprese di adottare delle cautele specifiche per sfruttare una importante leva competitiva senza esporsi a rischi significativi

La sostenibilità, intesa in senso ampio – ossia, intesa come l'insieme delle caratteristiche ambientali, sociali ed etiche di prodotti e aziende –, è un tema di grande attualità, costituendo un importante parametro di scelta per imprese e consumatori e, conseguentemente, una rilevante leva competitiva per gli operatori.
Ciò si traduce in una sempre maggiore attenzione da parte delle competenti autorità, e degli attori del mercato, consumatori, partner commerciali e concorrenti, sempre più propensi ad attivare le tutele amministrative e civilistiche (in particolare, azioni di risarcimento del danno e richieste di inibitorie).
Partendo dalle autorità, colpisce l'intensa attività di contrasto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Agcm" o "Autorità").
L'azione dell'Agcm
Nell'ultimo anno sono numerosi gli interventi dell'Autorità in materia.
Il 21 gennaio 2025, l'Agcm ha irrogato a diverse società del Gruppo GLS ("GLS"), attivo nella spedizione, trasporto e consegna di merci, una sanzione di 8 milioni di euro per pratiche commerciali, ingannevoli e aggressive, incentrate su vanti ambientali ambigui, non accurati e non verificabili.
In estrema sintesi, GLS ha adottato un progetto di sostenibilità ambientale denominato "Climate Protect", in forza del quale si proponeva, tra l'altro, di utilizzare energia verde nelle proprie strutture, impiegare veicoli per le consegne "a zero emissioni", realizzare edifici secondo elevati standard di sostenibilità e compensare le emissioni di CO2 del network GLS.
Tali iniziative sono state ampiamente pubblicizzate, anche tramite il sito internet, presso i consumatori, le imprese clienti e le aziende di trasporto affiliate al network di GLS (molte delle quali considerate "micro-imprese").
Secondo l'Autorità, i messaggi: (i) non consentivano di comprendere la profonda differenza tra attività di "compensazione" e attività di "riduzione" delle emissioni, lasciando intendere che le prime fossero idonee a "rendere meno inquinanti i servizi di spedizione offerti da GLS"; (ii) facevano riferimento a un certificato di compensazione non ancora ottenuto alla data della loro diffusione; (iii) contenevano dati non corretti o incompleti. Ad esempio, le informazioni necessarie per decodificare i claim "100% energia verde nelle nostre strutture" e "veicoli per le consegne a zero emissioni" non erano fornite in prossimità degli stessi, ma erano necessari "parecchi scroll della pagina web". Inoltre, tali informazioni sono state giudicate non puntuali, stante il fatto che le percentuali di strutture alimentate a energia verde e di veicoli elettrici utilizzati risultavano essere molto più contenute di quelle indicate nelle note (che già ridimensionavano significativamente i vanti ambientali contenuti nei claim).
Per di più, in merito alla contestazione circa la non chiara distinzione tra "compensazione" e "riduzione delle emissioni", il principio che dette attività non siano equivalenti e non possano essere confuse nella comunicazione è ben consolidato ed è stato cristallizzato dal legislatore europeo nella direttiva n. 2024/825 del 28 febbraio 2024 (su cui si tornerà a breve) che ha ricondotto a una fattispecie di pratica commerciale scorretta ingannevole "Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra".
Tornando al provvedimento, oltre a quanto sopra, diversamente da quanto dichiarato e con decisione unilaterale, GLS avrebbe traslato integralmente il costo del progetto Climate Protect su determinate imprese clienti e affiliate. In pratica, ciascuna impresa si sarebbe vista imporre un contributo a fronte del rilascio di un certificato, non richiesto, attestante la compensazione di CO2 riconducibile alla medesima impresa. Peraltro, detti certificati sono risultati inattendibili, in quanto basati su valori medi nazionali anziché su dati specifici delle singole imprese.
L'Agcm appare aver valutato la fattispecie con particolare severità, anche in ragione del fatto che "il trasporto delle merci è uno dei settori economici maggiormente inquinanti, che richiede particolare rigore e accuratezza alle imprese che vi operano e che decidono di promuovere la propria attività facendo leva sulle iniziative di sostenibilità ambientale (c.d. "green appeal")". Tanto è vero che l'Autorità ha rigettato gli impegni proposti dal Gruppo GLS per ottenere la chiusura del procedimento senza l'accertamento dell'infrazione "a causa della manifesta gravità e dell'elevato grado di offensività delle condotte contestate, anche in ragione del crescente interesse da parte di consumatori e imprese nei confronti della tematica dei claim ambientali".
Questa decisione segue numerosi altri recenti interventi dell'Autorità in materia di greenwashing.
Lo scorso 9 ottobre, infatti, l'Agcm ha dato notizia di un'attività di moral suasion in forza della quale sono stati rimossi profili di possibile scorrettezza da alcune comunicazioni pubblicitarie dei veicoli elettrici XEV YOYO e Microlino.
Tali comunicazioni, essendo formulate in maniera assoluta e generica (“100% sostenibile”, “100% Green”, “Zero emissioni”, ecc.), veicolavano messaggi di assenza di emissioni/impatto ambiente o di totale sostenibilità. Oltre a ciò, secondo l'Autorità, "non si indicava a quale aspetto e/o fase del ciclo di vita del prodotto si riferivano (es. produzione del veicolo e delle batterie, distribuzione, utilizzo, smaltimento del veicolo e delle batterie), considerando che occorre tener conto, tra l’altro, delle emissioni legate al mix dell’energia elettrica normalmente necessaria per la ricarica delle batterie ed all’uso delle autovetture.".
Il 25 settembre scorso, inoltre, l'Autorità ha avviato un procedimento, tutt'ora in corso, nei confronti della società che gestisce il sito italiano di e-commerce Shein, ipotizzando che alcune affermazioni ambientali presenti sul medesimo sito siano "generiche, vaghe, confuse e/o fuorvianti in tema di “circolarità” e di qualità dei prodotti e del loro consumo responsabile". Informazioni non puntuali verrebbero fornite in merito "alla quantità utilizzata di fibre “green”, "sulla non ulteriore riciclabilità dei capi d’abbigliamento" e sugli obiettivi raggiunti nell'ambito di un processo di decarbonizzazione delle attività. Anche in questo caso, l'Agcm sembrerebbe tenere conto dello specifico impatto ambientale del settore in cui opera la società oggetto di investigazione, ossia quello del cosiddetto “fast o super fast fashion”.
Considerando, poi, il "greenwashing" in senso ampio, vanno ricordati i procedimenti avviati, nel luglio del 2024, nei confronti di alcune società del gruppo Armani e del Gruppo Dior sulla base dell'ipotesi secondo la cui tali società "potrebbero avere presentato dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere, in particolare riguardo alle condizioni di lavoro e al rispetto della legalità presso i loro fornitori." In particolare, in contrasto con i claim diffusi, alcuni capi di abbigliamento sarebbero prodotti presso società terze che non rispettano i diritti dei lavoratori, pagando salari inadeguati, imponendo orari oltre i limiti di legge e "in condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti".
Le conseguenze anche civilistiche degli illeciti
Le pratiche commerciali scorrette, che possono costituire anche atti di concorrenza sleale, legittimano i danneggiati - consumatori e micro-imprese destinatari delle condotte, così come concorrenti - ad agire in giudizio per far valere i loro diritti.
Per quanto attiene alle azioni risarcitorie, si registrano numerose azioni collettive proposte dai consumatori e da microimprese.
Con specifico riferimento al greenwashing, il 15 maggio dell'anno scorso, Altroconsumo ha comunicato di aver trovato un accordo con Volkswagen per transigere la causa risarcitoria promossa nei confronti del costruttore tedesco in ragione della pretesa ingannevolezza dei claim ambientali dallo stesso diffusi. La tesi era che, in ragione di quanto emerso nel corso dell'arcinoto "Diesel Gate", le comunicazioni pubblicitarie di Volkswagen, incentrate sui valori della tutela ambientale e della responsabilità ecologica, non fossero veritiere.
In primo grado, il Tribunale di Venezia ha condannato la casa automobilistica a pagare la somma di 3.300 euro a ogni aderente all'azione di classe (circa 60.000). In secondo grado, la Corte di Appello ha considerevolmente ridotto il risarcimento per ragioni di prova. Infine, prima che la vicenda trovasse una definizione in Cassazione, Altroconsumo e Volkswagen hanno trovato un accordo, in forza del quale quest'ultima si è resa disponibile a versare agli aderenti alla azione di classe una somma complessiva pari a circa 50 milioni di euro.
Diverse sono le azioni inibitorie/risarcitorie promosse dai concorrenti nei confronti delle imprese.
In tema di scorrette comunicazioni di sostenibilità, il caso più noto è l'ordinanza inibitoria del Tribunale di Gorizia del 2021, ottenuta da Alcantara S.p.A. nei confronti dei messaggi pubblicitari del concorrente Miko S.r.l., giudicati "molto generici in alcuni casi – scelta naturale, amica dell'ambiente, la prima e unica microfibra che garantisce eco-sostenibilità [..] e sicuramente creano nel consumatore un'immagine green dell'azienda senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell'ambiente[..]". L'ordinanza è stata, poi, revocata dal medesimo tribunale in sede di reclamo, in ragione della mancata prova del pregiudizio imminente e irreparabile che giustificasse l'inibitoria (c.d. periculum in mora). Tuttavia, a prescindere dai profili procedurali, è pacifica la possibilità di utilizzare anche questo strumento laddove il concorrente alteri il confronto concorrenziale con una comunicazione sulla sostenibilità non corretta.
Il quadro normativo in evoluzione
Come noto, il quadro giuridico in materia è in continua evoluzione.
Il 6 marzo scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) n. 2024/825 sulla "responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde" ("Direttiva"). In concreto, la nuova normativa integra le discipline in materia di pratiche commerciali scorrette (tra le quali, le comunicazioni pubblicitarie ingannevoli) e di diritti dei consumatori nei contratti (ossia, rispettivamente, le direttive n. 2005/29/CE e n. 2011/83/UE, recepite in Italia in apposite sezioni del Codice del consumo). In punto di pratiche commerciali scorrette, vengono, tra l'altro: (i) fissati parametri specifici per l'utilizzo di vanti ambientali afferenti al raggiungimento di obiettivi futuri (piani adeguati, individuazione di budget proporzionati, verifiche periodiche da parte di soggetti terzi, ecc.); (ii) espressamente ricondotte a fattispecie illecite le comunicazioni che generano confusione tra compensazione e riduzione delle emissioni; (iii) vietate l'esibizione e l'utilizzo di marchi di sostenibilità che non siano stabiliti da autorità pubbliche o non siano basati su un sistema di certificazione che soddisfa specifiche e stringenti condizioni. Passando ai diritti dei consumatori, questi dovranno essere informati dal venditore, prima della conclusione di un contratto, circa la durabilità e la riparabilità dei prodotti. Laddove si tratti di beni con elementi digitali (ad esempio, una smart TV, un orologio o uno smartphone), contenuti digitali o servizi digitali, i consumatori devono ricevere indicazioni anche in merito al "periodo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software". Gli Stati membri hanno tempo sino al 27 marzo 2026 per recepire nei rispettivi ordinamenti le nuove disposizioni, le quali troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026.
È in corso, inoltre, l'iter di adozione della proposta di direttiva sui "green claims" ("Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims (green claims directive)"), che è stata approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 12 marzo 2024 e dal Consiglio europeo il successivo 17 giugno. Tra l'altro, la direttiva individua i criteri minimi da soddisfare per la formulazione delle asserzioni ambientali e i parametri specifici per quelle comparative, disciplina le modalità di comunicazione delle asserzioni ambientali, regola l'utilizzo dei "marchi ambientali" e impone la verifica e la certificazione delle asserzioni ambientali e dei marchi ambientali da parte di soggetti terzi indipendenti prima della loro diffusione.
Ci sono, poi, diversi altri provvedimenti che varrebbe la pena segnalare. Per ragioni editoriali, si cita solo il recente decreto legislativo n. 125/2024, con cui è stata recepita in Italia la direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria e di sostenibilità.
La norma è entrata in vigore lo scorso 25 settembre e, sostanzialmente, impone alle "imprese di grandi dimensioni" (ossia, imprese che abbiano superato almeno due delle seguenti soglie: 250 dipendenti; 25 milioni di euro di patrimonio netto e 50 milioni di euro di ricavi) e alle imprese piccole e medie quotate di includere "in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sua situazione".
Da ricordare che per "questioni di sostenibilità" si intendono "fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance".
Il decreto legislativo prevede un'applicazione scaglionata nel tempo, in base agli esercizi interessati: 1° gennaio 2024 per le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, 1° gennaio 2025 per le imprese di grandi dimensioni e, infine, 1° gennaio 2026 per le imprese piccole e medie quotate.
Sul punto, però, si ricorda che, il 26 febbraio u.s., la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di proposte per semplificare la normativa sulla sostenibilità, tra le quali quella di posticipare di due anni (fino al 2028) gli obblighi di informativa per le imprese che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD.
Commento Osborne Clarke
Sia per non perdere terreno sul mercato, sia per adempiere a obblighi di legge, le imprese possono trovarsi nella necessità di comunicare la propria posizione in materia di sostenibilità.
In concreto, il tema non pone di per sé sfide insuperabili o estremamente rischiose; se si parte dal presupposto che la comunicazione deve essere sempre corretta, veritiera e trasparente, bastano pochi accorgimenti per evitare rischi superflui.
Un primo passo è sicuramente quello di individuare esattamente il reale contributo dell'impresa alla sostenibilità e porlo al centro della comunicazione, costruendo un messaggio che, pur rimanendo "accattivante", non ne stravolga il senso.
Sul punto, non è vero che esperti di marketing e avvocati sono destinati a non capirsi: le due figure dialogano costruttivamente da sempre, ma devono iniziare a confrontarsi sin dall'inizio di un progetto, in modo da individuare da subito il linguaggio e le modalità espressive corrette per consentire alle imprese di utilizzare le proprie risorse in maniera più efficiente e di raggiungere i propri obiettivi contenendo il più possibile i rischi.